DIF-DOO
Ribofunk (racconti,
1996) – Scab’s Progress (con Bruce
Sterling, racconto, 2000) – Shipbreaker (racconto,
2002) – Neutrino Drag (racconto,
2004)
Scriveva Roland Barthes che quel che accomuna Sade, Fourier
e Loyola è il fatto che tutti e tre fossero dei fondatori di lingue, prima
ancora che di utopie, sacrifici o supplizi. Questo problema investe anche
qualsiasi scrittore di fantascienza che, nell’immaginare un futuro, si trova
costretto a inventarsi anche le parole che vadano assieme a quel futuro. Con
l’aggravante che il loro lettore vive invece in questo presente e che quindi
avrà bisogno sempre di qualche spiegazione per qualunque neologismo. Qui si
gioca la riuscita o meno di ogni scrittura fantascientifica. Questo per dire
che Philip Dick e William Gibson sì. Sterling e Egan a tratti. Paul Di Filippo
con fatica.
Di Filippo costruisce un suo mondo pieno di organismi
geneticamente inediti, in cui va considerato umano chi possiede almeno un 51%
di patrimonio genetico umano (ibridato comunque con pezzi di altri animali).
Chi è sotto il 51% è soltanto uno “spice” e dunque uno schiavo. Poi Di Filippo
usa “eft” per dire dollari, “dirty harry” per poliziotto ecc... Il suo guaio è
che non sa dove fermarsi. Ci sono intere frasi in cui le uniche parole di
inglese corrente sono “if”, “then” e “watermelon”. E questo affatica la lettura
(per non parlare dell’eventuale traduttore). Di Filippo è bravo a inventare, ma
esagera. Come direbbero gli americani: “too much of a good thing”.
Fup (1983)
Il nonno ha 99 anni e beve solo Ol’ Death Whisper, un whisky
fatto in casa che lo rende immortale (o almeno così gli ha detto l’indiano che
in punto di morte gli ha dato la ricetta). Tiny è il nipote e passa il tempo a
costruire staccionate e a lottare contro il suo nemico mortale, un cinghiale di
nome Lockjaw. Fup è un’anatra selvatica (Fup
duck. Do you get it? Fucked Up) e si rifiuta di volare. Al drive-in ci
vanno perché Tiny e il nonno amano i western (ma il nonno sta sempre dalla
parte dei banditi), mentre Fup preferisce i film romantici. Poi Fup muore e
risorge, Lockjaw muore e basta, Tiny smette di costruire staccionate e Jake, il
nonno, muore il giorno dopo aver compiuto un secolo. E il suo ultimo pensiero
prima di morire è “Well goddamnit, I was immortal till I died”.
Ma questo non è niente (è l’opera prima di Jim Dodge, lunga
una cinquantina di pagine appena). Piuttosto vi consiglio (I suggest you, I
urge you, I beg you, I implore you) di leggere Not Fade Away e soprattutto Stone
Junction. An Alchemical Potboiler, un libro nel quale potrete anche
scoprire come si fa a diventare invisibili. Non vi stupirà sapere che la
prefazione gliel’ha scritta Thomas Pynchon.
Le Gorille et le barbu
(1955) – Le Gorille se mange froid
(1955)
Prolifico è dire poco. Tra il ‘54 e il ‘61 riesce a scrivere
più di 50 romanzi. Anno di grazia è il 1956 quando ne fa uscire uno al mese. Nel
1978 riparte con una collana tutta sua (edita da Plon) nella quale pubblica
soltanto 21 nuovi titoli in sei anni. Chissà forse la vecchiaia.
Il suo protagonista è una “barbouze”, una spia un po’
ruspante (è così grande e grosso che lo chiamano il Gorilla), ancora lontana
dai gadget tecnologici di 007, immersa in un mondo uscito da poco da una guerra
mondiale in cui tutte le spie di tutti i paesi si conoscono per nome e si
rispettano l’un l’altra.. Fa quasi tenerezza leggerlo ora, col suo gergo un po’
démodé, con i suoi tentativi mal riusciti di darsi uno stile originale (la nuit était picasseé d’étoiles), con
le sue note a pie’ pagina per spiegare cos’è un Rosbiff, cos’è la Boite,
cos’è un walkie-talkie. Insomma è un
po’ naif, un po’ sempre tutto uguale, ma si lascia leggere. E poi perché mai
dovrei giustificarmi se mi piacciono i libri di A. L. Dominique?
Asphodel (1922) – End to Torment (1958) – The Gift (1960) – Tribute to Freud (1956)
Se cercate dei ragionieri in questa storia o almeno degli
avvocati o dei medici, andrete delusi. Hilda Doolittle, poetessa, nasce a
Bethlehem, Pennsylvania, il 10 settembre 1886. Al college conosce Williams
Carlos Williams, si fidanza con Ezra Pound, poi, quando quello lascia gli Stati
Uniti, s’innamora di Frances Josepha Gregg (studentessa di belle arti e futura
poetessa). Arrivata a Londra ritrova Ezra Pound e diventa amica di D.H.
Lawrence, ma il rapporto finisce male (H.D./D.H. era una storia nata male, fin
dalle iniziali). Nel 1913 sposa Robert Aldington, poeta, qualche anno più tardi
fa una figlia con Cecil Gray, musicista. La figlia si chiama Perdita e durante
la Seconda guerra mondiale sarà una delle ragazze di Bletchley Park, il luogo
in cui lavorava Alan Touring (se avete visto il film The Imitation Game, sapete di cosa sto parlando). Uno dei figli di
Perdita, Nicholas Schaffner, sarà musicista, giornalista, nonché autore di
libri sui Beatles e i Pink Floyd. Non c’è niente da fare, non c’è nessuno in questa
storia che non abbia del talento, quello che si chiama “the gift”.
Nel ’19 Hilda conosce Bryher (Annie Winifred Ellerman),
scrittrice e miliardaria. Sarà una relazione che durerà più di trent’anni. Una
relazione che passa a tre quando Bryher sposa nel ’21 Robert McAlmon, scrittore,
poeta, nonché autore del libro Being
Geniuses Together (niente di meno). Nel ’27 Bryher, in capo a tre mesi,
divorzia da McAlmon per sposare Kenneth McPherson, scrittore, fotografo e
futuro regista. Il nuovo ménage à trois
è particolarmente fertile perché vede la nascita di Close Up, la prima rivista di cinema al mondo che si basi sul
presupposto che il cinema sia una forma d’arte (all’epoca non era così
evidente). McPherson fonda anche una casa cinematografica, The Pool Group, e
realizza vari cortometraggi, più un film di finzione, Borderline (1930) di cui Hilda è protagonista (vedi foto).
McPherson dopo la guerra andrà a vivere a Capri, assieme al suo amante Algernon
Islay de Courcy Lyons, fotografo. Alla sua morte, nel 1971, verrà sepolto a
Cetona. La sua biblioteca personale verrà acquisita (grazie a Michele Canosa)
dalla Biblioteca della Cineteca di Bologna “Renzo Renzi” (chiedete ad Anna
Fiaccarini o a Cesare il permesso per consultarla).
Agli inizi degli anni ’30 Hilda Doolittle va in analisi, ma
lei che è amica di Havelock Ellis (psicologo e sessuologo) non va da un
analista qualunque, va direttamente dal numero uno: Sigmund Freud. Il resoconto
che Doolittle pubblica nel 1956 è un capolavoro di reticenza. Freud è
affascinato dalla cultura e dal talento di H.D., ma soprattutto è interessato
alla sua bisessualità. Di tutto questo non c’è traccia nel libro. Di sesso non
si parla mai. Hilda parla di miti greci, statuette etrusche, banalità familiari
(Freud amava i cani, ma odiava i gatti: “sono come le scimmie, non ci danno la
soddisfazione di essere come noi, né di essere i nostri nemici”). A un certo
punto s’inventa una palla micidiale su delle figure che avrebbe visto
materializzarsi su un muro di una stanza in Grecia, ma non dice nulla delle sue
pulsioni sessuali. Parla volentieri della sua infanzia (ma di quella ne avevamo
già abbastanza dopo aver letto The Gift).
Parla anche di Pound (Freud si dice convinto che sarebbe stato capace di
aiutarlo), anche se poi Pound non credeva alla psicanalisi. “Ti sei messa nella
porcilaia sbagliata. Ma ne puoi sempre uscire fuori” dice a Hilda quando lei
gli comunica di aver iniziato l’analisi. Ma, di nuovo, sul suo rapporto con
Pound sapevamo già tutto dopo aver letto End
to Torment. O meglio, non sapevamo granché visto che le sue reticenze anche
qui sono colossali a partire dal fatto che ogni volta che Hilda scrive di
essere stata fidanzata con Pound non manca mai di virgolettare la parola. Anche
se poi è innegabile che sia stato lui a lanciarla, a troncarla nel nome e nel
cognome, a trasformare la giovane e inesperta Hilda Doolittle nella celebre
“H.D. Imagiste”.
Del suo rapporto con Pound ci sono tracce anche in Asphodel che è in realtà un roman à clef con Pound che diventa
George Lowndes, Aldinton che si chiama Darrington e Bryher che diventa Beryl de
Rothfeld. Il romanzo copre il periodo che va dall’arrivo di Hilda in Europa
fino alla nascita di Perdita, ma naturalmente non è un romanzo convenzionale. È
piuttosto un procedere per iterazioni ossessive, per echi letterari e
linguistici, per immagini pure (la ragazza non per niente è Imagiste).
Siamo arrivati alla fine della storia e non ho accennato, se
non di sfuggita, a quella che è stata la sua attività centrale, la poesia (ma
per leggerla basta andare su Project Gutemberg). È che Hilda ha avuto una vita
intensa, È sopravvissuta a due guerre, ha sofferto problemi fisici e mentali,
ha viaggiato per il mondo, è andata a letto indifferentemente con uomini e
donne, ha studiato i miti greci dell’antichità e ha esplorato le possibilità
della moderna arte cinematografica, infine ha scavato profondamente nei confini
della sua arte, la poesia. Credo che alla fin fine si sia divertita.
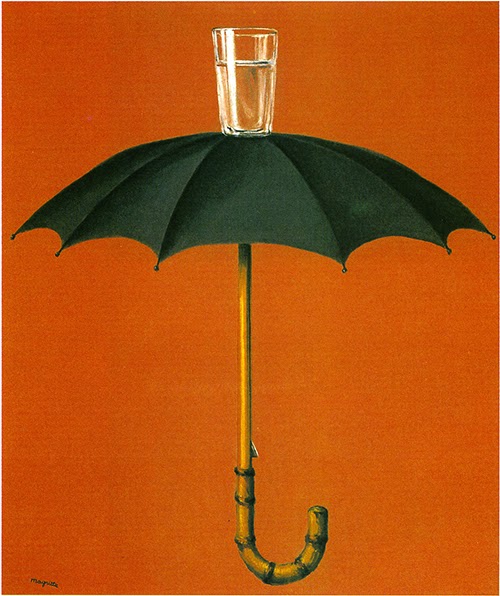





Nessun commento:
Posta un commento