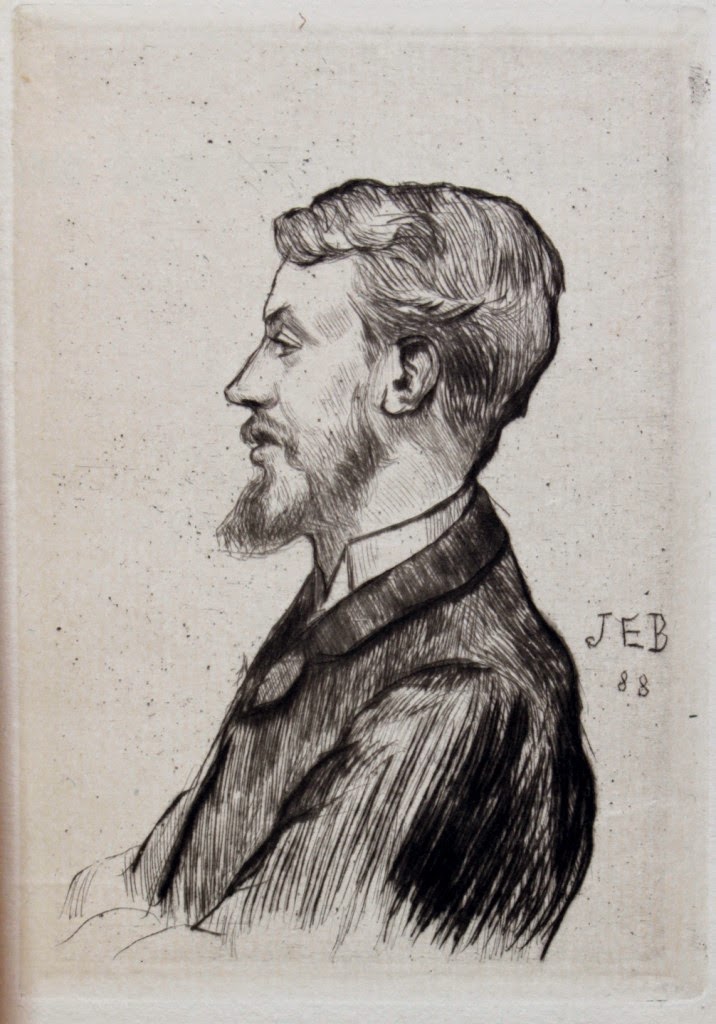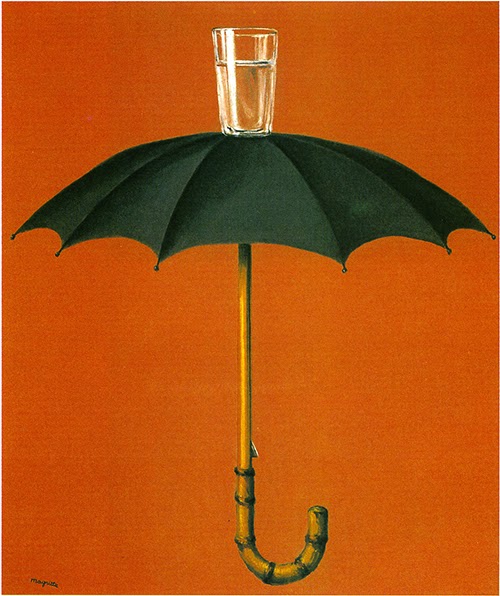FAN-GAR
The Brotherhood of the Grape (1977) – Wine of Youth (racconti, 1985)
Come si fa a non
amare John Fante? Soprattutto dopo aver letto Chiedi alla polvere e Aspetta
primavera, Brandini. Dopo aver letto tutto quello che ha scritto, comprese
le cose meno riuscite come Dreams from
Bunker Hill. Poi arrivi alla fine e apri con trepidazione The Brotherhood of the Grape e un po’ ti
dispiace perché è l’ultimo, è l’unico che ti manca. E scopri che è la storia di
uno scrittore di origine italiana con un padre alcolista, scorbutico e fumatore
di Toscanelli e con una madre eternamente piangente, ma bravissima a cucinare
spaghetti e pollo alla cacciatora. E poi vieni a sapere che il padre, ormai anziano, vuole
metter mano alla sua ultima opera di mastro muratore e quindi costringe il
figlio scrittore ad aiutarlo ecc... Possibile che John Fante non abbia mai parlato
d’altro? Possibile che in tutta la sua vita abbia scritto sempre lo stesso
libro?
The Big Clock / No Way Out (1946) – The Generous Heart (1954)
Francis Lacassin,
nel suo Mythologie du roman policier
(10/18, 1974, 2 voll.), dedica un intero capitolo a Kenneth Fearing. In
particolare di The Big Clocks scrive:
“chef-d’oeuvre déjà oublié d’un americain inconnu”. I francesi adorano queste
cose. Se dai loro discorsi critici elimini le espressioni “capolavoro
dimenticato” e “genio misconosciuto”, non rimangono che due o tre preposizioni
articolate, tre avverbi, più l’aggettivo incontournable.
In realtà Kenneth Fearing non era un genio, però scriveva poesie ed era anche mezzo
comunista e questo è quel che basta a un critico francese medio per lasciarsi
andare all’iperbole. The Big Clock, è
vero, è un buon libro (l’hanno portato al cinema un paio di volte). Poi quando
leggi anche The Generous Heart scopri
che sono costruiti tutti e due allo stesso modo: ogni capitolo ha la sua voce
narrante. Questa variabilità del punto di vista permette di imbrogliare bene la
trama, di nascondere gli indizi, insomma, di tenere il lettore in sospeso tra
quel che gli dicono e quel che succede realmente. Dunque Kenneth Fearing è
bravo, è da leggere, è uno scrittore interessante, mais pas tellement.
Fogwill, Rodolfo Enrique
Muchacha Punk (racconto, 1980)
Fogwill lavorava
in pubblicità quando il successo di questo racconto breve lo convinse a dedicarsi
al più duro e ingrato mestiere di scrittore. Poteva anche risparmiarselo.
Rosario Tijeras (1999)
Sullo sfondo ci
sono i narcos. In primo piano c’è lei Rosario Tijeras, donna fatale, perduta,
assassina (con le forbici, naturalmente), tenera amante ecc... Il romanzo
dovrebbe essere un thriller mozzafiato e sanguinolento (in Colombia ne hanno
fatto pure una serie tv), in realtà è semplicemente una storia d’amore. Il caso
è classico, lui ama lei, ma lei ama l’amico di lui. Il fatto che i due maschi
del trio vengano da famiglie borghesi, mentre lei è una malafemmena, rende il tutto un po’ ovvio. Vediamo tutto dal punto di
vista del maschio sfigato, quello che arriva a rovinarsi la vita pur di
restarle accanto. E questo spegne un po’ la tensione. Ma il personaggio di
Rosario è di quelli che non si dimenticano.
Tinta roja (1998)
Alberto Fuguet è
cileno, dunque è sudamericano, dunque scrive libri con gli uccelli che parlano
e i vecchi che non muoiono mai (il realismo magico di García Márquez, per
intenderci). Tutto sbagliato. Allora ricominciamo da capo. Alberto Fuguet è
cileno e scrive libri sul Cile attuale, così come capita in tutti i paesi del
mondo. Questo è la storia di un apprendista giornalista di nera che vorrebbe
diventare scrittore. Fuguet è bravo ad andare avanti per flash, tra
ammazzamenti, suicidi, bassezze varie e sprezzanti dichiarazioni di cinismo.
Memorabile il personaggio di Faúndez, il capocronaca, quello che tiene nel
cruscotto le foto dei morti ammazzati per andare, di lì a qualche settimana, a
portarli alle vedove col dichiarato intento di consolarle a letto. Esiste tutta
una letteratura oltre García Marquez. E in diversi casi è anche buona.
Noticia de un secuestro (1996) – Memoria de mis putas tristes (2004)
Ok, García Márquez è quello che scrive libri con gli uccelli
che parlano e con i vecchi che non solo non muoiono mai, ma non smettono
neppure a ottant’anni di scopare. Però quanto è bravo a scrivere. Memorias de mis putas tristes è il suo
ultimo romanzo è non è tra le sue cose migliori, ma prendete un libro come Noticia de un secuestro. Di fatto è un
reportage su un caso di cronaca e quindi è pieno zeppo di personaggi reali. Per
un colombiano saranno tutti famosi, ma un non colombiano fa fatica a seguirli.
Eppure lo leggi lo stesso d’un fiato. (Gabo da giovane faceva il giornalista e
si sente).